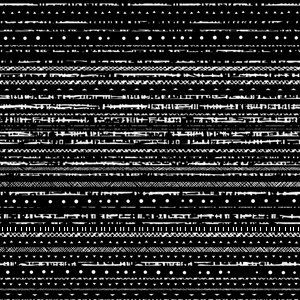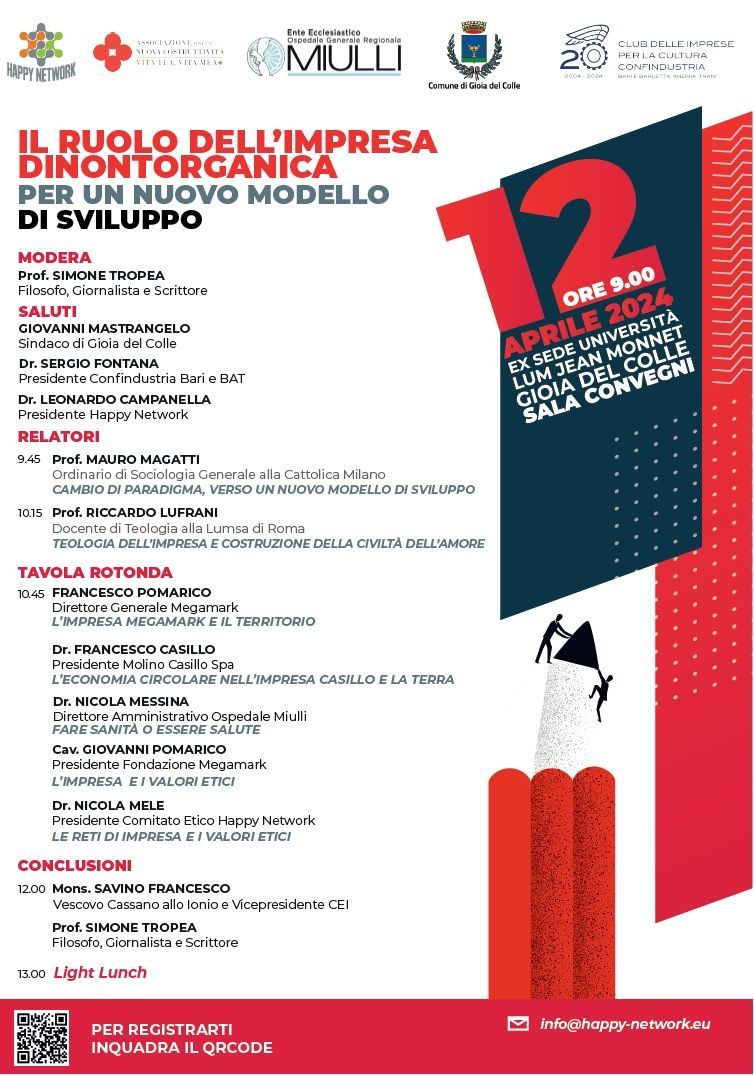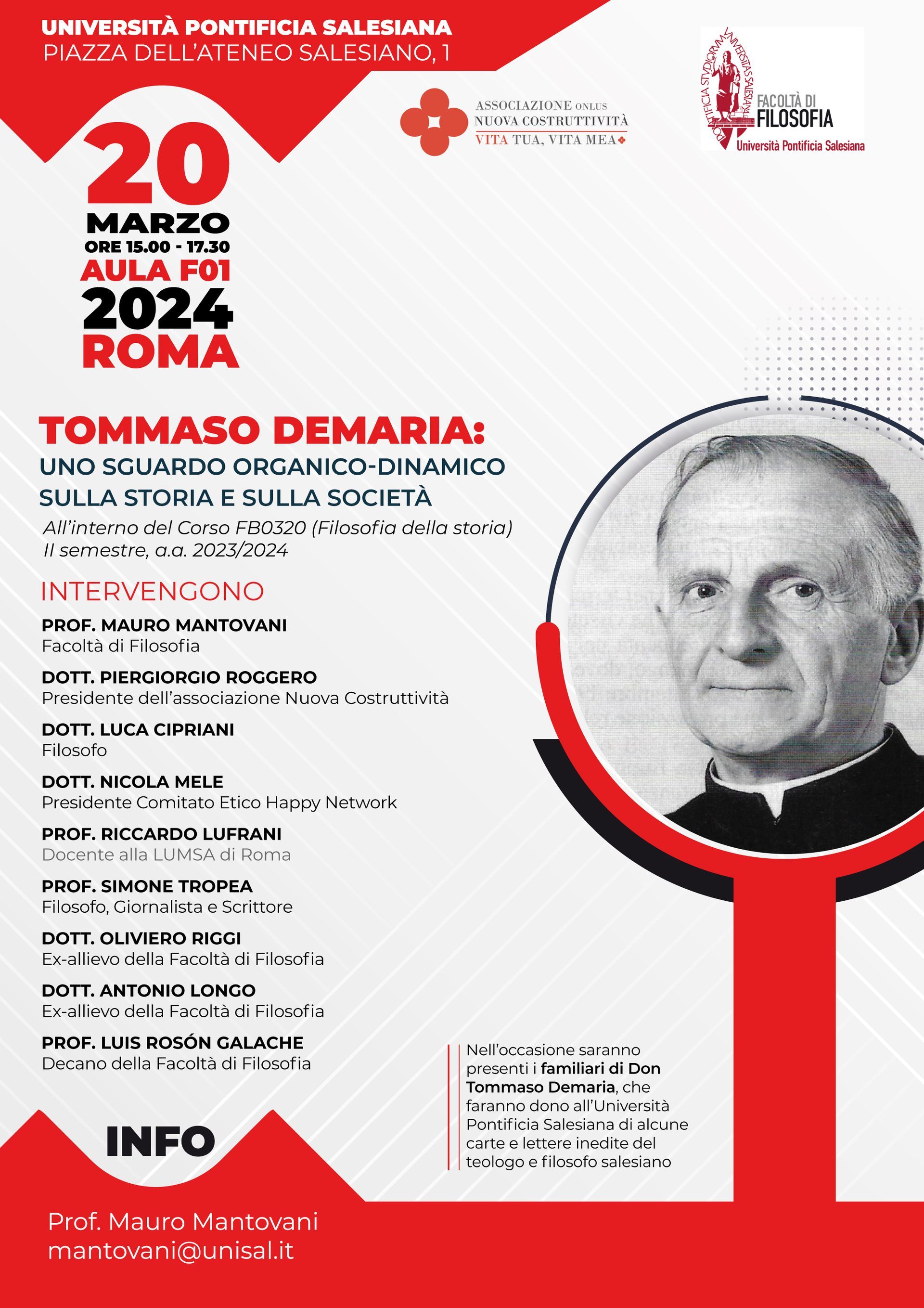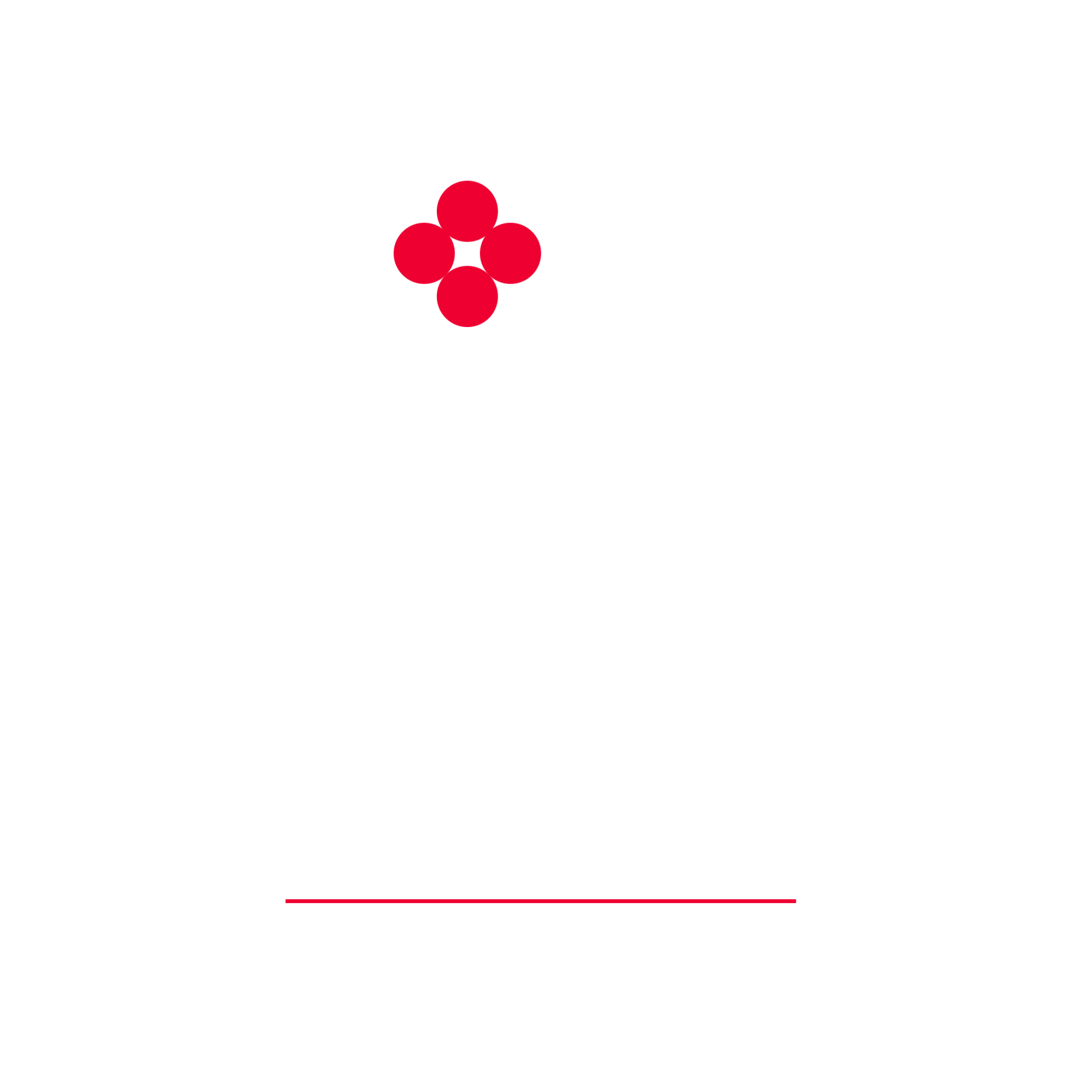MiD revolution, la risposta alla crisi
Non sia mai detto che il MID, dopo 50 anni di incubazione, manchi di indicare al mondo la strada di uscita dalla crisi. Strada ovvia e nello stesso tempo insospettata.
Rapporto tra gratuità ed economia nel mondo dinotorganico
Costruire un modello economico sociale significa dare a ciascun uomo da oggi all’eternità ( se il modello è Vero) la possibilità di costruire la propria azione in modo che essa risulti valida per ciascuno nella sua vita sociale ed economica.
Come fare? Scrivere trilioni di papiri per descrivere ogni singola situazione presente o possibile, o definire un unico criterio in modo che ciascuno possa elaborare autonomamente la sua vita sociale, politica ed economica nel modo più consono alla sua situazione?
“Modello per tutti” significa indicazione di un unico criterio di sviluppo (= sapienza) che anima tanto l’agire economico quanto quello sociale
La risposta è scontata in quanto l’unica strada percorribile è quella di mettere a punto IL criterio per costruire il nuovo modello dell’agire umano. Il MID, e con esso tutto il mondo profano , per cambiare rotta ha bisogno di una “Nuova” Sapienza.
L’esplicitazione di questa sapienza nella sua dimensione economica e umana è già stato fatto e qui rimandiamo al precedente studio sull’argomento
Illustrazione 1: Due aree di sintesi (in verde) operate dai trascendentali, sapienza mercato e sapienza persona-cellula
Oggi ci preme evidenziare il meccanismo della produttività metafisica (ossia della sapienza che presiede alla produttività) nella sua relazione con l’economicità monetaria e per farlo osserviamo le aree di sintesi tra la sapienza umana ed economica.
Le aree della sintesi
Nell’immagine precedente queste aree sono rappresentate dalle zone cerchiate in verde: esse contengono i processi di sintesi tra sapienze costruttive, processi resi evidenti dalla presenza dei trascendentali sintetici della socialità e della missionarietà.
Si tratta di sapienza (criterio costruttivo), e per questo il nome con cui le aree sono state battezzate sono solo indicativi:
- la prima contiene i criteri costrutti della sintesi tra strutture sociali e strutture economiche ed è perciò stata chiamata “ mercato”
- la seconda i criteri costruttivi della sintesi tra famiglia e comunità ed è perciò stata chiamata “ ideoprassi persona-cellula”
Agire per l’economia industriale significa agire principalmente attraverso la moneta
Per intuire il meccanismo che è in funzione pensiamo per un attimo ai loro strumenti. Lo scambio a distanza che avviene tra strutture economico industriale e strutture sociali nel mercato può avere un solo intermediario, la moneta. È un intermediario inevitabile. Come infatti posso convincere un pescatore dei mari del Nord ad uscire con la barca per procurarsi il merluzzo da essicare per fare il mio baccalà? Lo scambio a distanza può avvenire solo col denaro.
Agire secondo la sapienza di tipo familiare significa agire agire attraverso un rapporto gratuito
Di tutt’altra natura è lo scambio della seconda area verde, la persona cellula. Essa scambia con famiglia e comunità . Non si può creare né l’una né l’altra senza una sapienza che preveda il rapporto gratuito . Pagate vostra moglie per le sue prestazioni? O prestate i soldi a vostro figlio per la scuola per poi farveli restituire quando lavorerà?
Il bilanciamento socio-economico alla base della produttività del Sistema
La “disgrazia” è che la realtà che stiamo osservando è sapienza, e proprio per questo è universale. La matrice mi mostra su un piano un ciclo che a suo tempo abbiamo chiamato “piani dell’essere”. Si tratta di cicli e quindi per compiere una sola singola azione DEVO coinvolgere entrambe le aree, quella “monetaria” e quella della “gratuita” facendo in modo che si completino e si rafforzino.
Quanto dell’una e quanto dell’altra?
L’azione sarà tanto più costosa quanto meno sarà coinvolta la persona-cellula: ovvio, perché di conseguenza si espande l’area che usa come suo strumento la moneta. Per questo l’ideoprassi liberal-capitalista ( che effettua ogni scambio esclusivamente su base monetaria) sarà sempre e irrimediabilmente più costosa dell’ideoprassi dinontorganica.
COME SI ESCE DALLA CRISI? SPOSTANDO L’AZIONE VERSO L’AREA GRATUITA
Detto in altro modo : Si esce (re)imparando a costruire la sapienza familiare e comunitaria
L’esempio
Caso1: raccolta di olio esausto
Il caso è quello di un’azienda raccoglie olio alimentare esausto per venderlo ad un’altra ditta che lo purifica e ne fa carburante.
Il costo della sua raccolta dipende dalle due componenti gratuita e monetaria.
Es.:gli incaricati dell’azienda passano presso l’appartamento a raccogliere l’olio. I due costi si sommano
- Costo Monetario: Questo costo è quantificabile in 1,5 euro e riguarda lo stipendio della persona che deve uscire con il furgone, parcheggiare… suonare il campanello… versare l’olio nel proprio bidone.
- Costo Sociale: Questo costo non è quantificabile perché non avviene attraverso la moneta. Va dal versare l’olio al momento dell’apertura della scatoletta fino a … rispondere al campanello… portare in casa il contenitore per la raccolta vuoto pronto per una prossima volta.
L’azione che osserviamo è “monetaria&gratuita” insieme e costa ora 1,5€.Poiché l’olio vien pagato dall’acquirente che lo trasforma in carburante 0,80€ la raccolta dell’olio alimentare esausto NON è possibile.
Come si aumenta la produttività? Si aumentano le competenze sociali. Per esempio come segue
- Costo sociale: Chiedo agli inquilini di portare l’olio fino ad un apposito contenitore posto nel giardino. Come vediamo la componente sociale dell’azione è aumentata perché devono scendere le scale,.. ecc.
- Costo monetario: il costo della raccolta si abbassa di 2/3 e va a 0,50€ perché l’operatore non deve più suonare ogni campanello.
La raccolta dell’olio alimentare esausto diventa POSSIBILE. Questo però ha richiesto il cambiamento dei comportamenti della popolazione.
Caso2: case popolari
Le persone invecchiano e a un dato momento della loro vita non sono autosufficienti: è un dato.
Anche la possibilità di sopravvivere è legata contemporaneamente al fattore monetario e sociale
- Costo sociale: è la quantità di tempo impegnata gratuitamente dalla società che è in questo caso specifico è rappresentata dalla famiglia
- Costo monetario: la quantità di denaro (attraverso la pensione o casa di riposo) sufficiente per pagare una badante o figura analoga.
Basta tornare indietro di cinquat’anni per vedere come sono cambiati i rapporti.
- Costo sociale: elevatissimo perché la famiglia si organizzava per badare all’anziano. Occorreva tempo.
- Costo monetario: bassissimo fino a farsi bastare delle pensioni che oggi giudicheremo “da fame”
Oggi la situazione è opposta
- costo sociale: basso. I figli spesso sono svincolati dall’accudimento dei genitori che dal momento della loro non completa autosufficienza vivono in modo autonomo e solitario.
- costo monetario: elevatissimo in quanto per permettere il perpetuarsi di questa situazione abbiamo bisogno di pensioni elevate adatte a pagare la badante direttamente, o indirettamente attraverso lo stato la casa di riposo
Come nel primo caso per mettere mano a questa situazione occorre variare il rapporto tra sapienza costruttiva della persona-cellula e quella economica. É la sapienza che costruisce i comportamenti economici.
Tante cose sono necessarie per cambiare la situazione degli anziani, ma oggi ci occupiamo solo della seguente. La persona inizia col pensarsi come badante ma evidentemente questo pensiero da solo non basta, occorre anche poter tenere il genitore vicino a sé. Ecco che un comune lo può favorire prevedendo nel suo piano regolatore alloggi più grandi (fino ad oggi non conviene) accanto ad alloggi più piccoli da assegnare al genitore.
L’aspetto fondamentale è ancora questo: la leva si trova in un diverso modo di educare al sociale le persone, che a sua volta genera una organizzazione sociale e di conseguenza una diversa organizzazione economica.
Come si esce dalla crisi?
L’obbiettivo può essere solo quello di mantenere l’attuale ricchezza reale , non quello di essere tutti più poveri. La soluzione suggerita dalla crisi è semplice: cambiare i comportamenti sociali e coordinarne lo sviluppo con l’economia attraverso i piani dell’essere . Dobbiamo infatti operare sull’agire umano in modo contemporaneo, anche se non su tutto l’agire umano contemporaneamente: Produttività Metafisica in funzione dell’economicità monetaria.
Faccio notare che in questo caso cambiare il comportamento sociale ha fatto sì (nel primo caso presentato) che si potessero creare posti di lavoro che altrimenti sarebbero andati persi: l’olio sarebbe continuato a fluire dagli acquai. Sono posti UTILI e IMPOSSIBILI da ottenere senza lavorare sulla sapienza che costruisce il sociale.
Il modo può essere solo quello di modificare la produttività ideoprassica agendo sulla gratuità attraverso l’educazione della persona-cellula, modificata attraverso una costruzione “con regole diverse” della comunità e della famiglia.
( segue in: Produttività metafisica e reale di sistema )
Cosa ne dice la Caritas in Veritate
La CHIESA in questo processo sapienziale ha evidentemente un grande compito.
… La convinzione poi della esigenza di autonomia dell’economia, che non deve accettare “influenze” di carattere morale, ha spinto l’uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino distruttivo. A lungo andare, queste convinzioni hanno portato a
sistemi economici, sociali e politici che hanno conculcato la libertà della persona e dei corpi sociali e che, proprio per questo, non sono stati in grado di assicurare la giustizia che promettevano
. Come ho affermato nella mia Enciclica Spe salvi, in questo modo si toglie dalla storia la speranza cristiana [86], che è invece una potente risorsa sociale a servizio dello sviluppo umano integrale, cercato nella libertà e nella giustizia. La speranza incoraggia la ragione e le dà la forza di orientare la volontà [87]. È già presente nella fede, da cui anzi è suscitata. La carità nella verità se ne nutre e, nello stesso tempo, la manifesta. Essendo dono di Dio assolutamente gratuito, irrompe nella nostra vita come qualcosa di non dovuto, che trascende ogni legge di giustizia. Il dono per sua natura oltrepassa il merito, la sua regola è l’eccedenza. Esso ci precede nella nostra stessa anima quale segno della presenza di Dio in noi e della sua attesa nei nostri confronti. La verità, che al pari della carità è dono, è più grande di noi, come insegna sant’Agostino [88]. Anche la verità di noi stessi, della nostra coscienza personale, ci è prima di tutto “data”. In ogni processo conoscitivo, in effetti, la verità non è prodotta da noi, ma sempre trovata o, meglio, ricevuta. Essa, come l’amore, « non nasce dal pensare e dal volere ma in certo qual modo si impone all’essere umano » [89].Perché dono ricevuto da tutti, la carità nella verità è una forza che costituisce la comunità, unifica gli uomini secondo modalità in cui non ci sono barriere né confini. La comunità degli uomini può essere costituita da noi stessi, ma non potrà mai con le sole sue forze essere una comunità pienamente fraterna né essere spinta oltre ogni confine, ossia diventare una comunità veramente universale: l’unità del genere umano, una comunione fraterna oltre ogni divisione, nasce dalla con-vocazione della parola di Dio-Amore.
Nell’affrontare questa decisiva questione, dobbiamo precisare, da un lato, che la logica del dono non esclude la giustizia e non si giustappone ad essa in un secondo momento e dall’esterno e, dall’altro, che lo sviluppo economico, sociale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità.,
Benedetto XVI,CARITAS IN VERITATE,4.CAPITOLO TERZO 4.FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETÀ CIVILE
La grande sfida che abbiamo davanti a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo tempo di globalizzazione e resa ancor più esigente dalla crisi economico-finanziaria, è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi dell’etica sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica. Ciò è un’esigenza dell’uomo nel momento attuale, ma anche un’esigenza della stessa ragione economica. Si tratta di una esigenza ad un tempo della carità e della verità .,Benedetto XVI,CARITAS IN VERITATE,4.CAPITOLO TERZO 4.FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETÀ CIVILE
Quando la logica del mercato e quella dello Stato si accordano tra loro per continuare nel monopolio dei rispettivi ambiti di influenza, alla lunga vengono meno la solidarietà nelle relazioni tra i cittadini, la partecipazione e l’adesione, l’agire gratuito, che sono altra cosa rispetto al “dare per avere”, proprio della logica dello scambio, e al “dare per dovere”, proprio della logica dei comportamenti pubblici, imposti per legge dallo Stato. La vittoria sul sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione. Il binomio esclusivo mercato-Stato corrode la socialità, mentre le forme economiche solidali, che trovano il loro terreno migliore nella società civile senza ridursi ad essa, creano socialità. Il mercato della gratuità non esiste e non si possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti. Eppure sia il mercato sia la politica hanno bisogno di persone aperte al dono reciproco. ,Benedetto XVI,CARITAS IN VERITATE,4.CAPITOLO TERZO 4.FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETÀ CIVILE
38. Il mio predecessore Giovanni Paolo II aveva segnalato questa problematica, quando nella Centesimus annus aveva rilevato la necessità di un sistema a tre soggetti: il mercato, lo Stato e la società civile [92]. Egli aveva individuato nella società civile l’ambito più proprio di un’economia della gratuità e della fraternità, ma non aveva inteso negarla agli altri due ambiti. Oggi possiamo dire che la vita economica deve essere compresa come una realtà a più dimensioni: in tutte, in diversa misura e con modalità specifiche, deve essere presente l’aspetto della reciprocità fraterna. Nell’epoca della globalizzazione, l’attività economica non può prescindere dalla gratuità, che dissemina e alimenta la solidarietà e la responsabilità per la giustizia e il bene comune nei suoi vari soggetti e attori. Si tratta, in definitiva, di una forma concreta e profonda di democrazia economica. La solidarietà è anzitutto sentirsi tutti responsabili di tutti [93], quindi non può essere delegata solo allo Stato. Mentre ieri si poteva ritenere che prima bisognasse perseguire la giustizia e che la gratuità intervenisse dopo come un complemento, oggi bisogna dire che senza la gratuità non si riesce a realizzare nemmeno la giustizia. Serve, pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all’impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d’impresa e dunque un’attenzione sensibile alla civilizzazione dell’economia. Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso .,Benedetto XVI,CARITAS IN VERITATE,4.CAPITOLO TERZO 4.FRATERNITÀ, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIETÀ CIVILE
The post MiD revolution, la risposta alla crisi appeared first on .
Seguici e commenta su Twitter
Seguici e commenta su Facebook